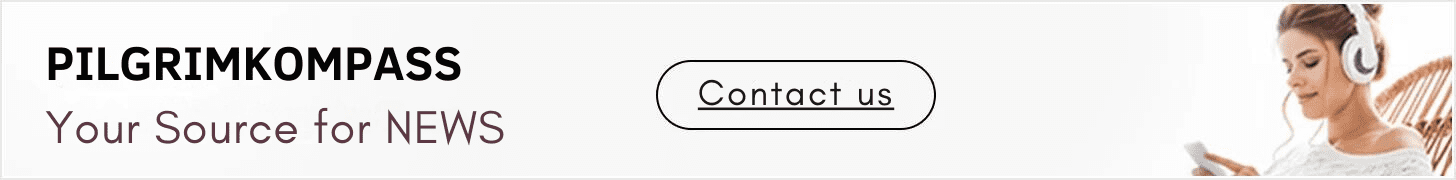Il testo seguente è tratto dall’intervento di Piero Vietti al Summer Workshop organizzato da Polidemos, il Centro per lo studio della democrazia e dei mutamenti politici dell’Università Cattolica del Sacro Cuore, tenutosi il 19 e 20 luglio 2023 a Venezia. Questo intervento fa parte del volume curato da Damiano Palano “Il futuro della democrazia italiana – Politica e società al tempo del governo Meloni”, recentemente pubblicato e scaricabile gratuitamente qui.
Nel presente intervento, esplorerò il paesaggio attuale dei media e della comunicazione democratica, identificando le tensioni presenti e proponendo un possibile punto di convergenza. Lo farò da una prospettiva privilegiata, ossia quella di un giornalista che vive e osserva queste dinamiche. Se dovessi individuare una linea di tensione, o addirittura di frattura, che ha caratterizzato gli ultimi anni della storia politica e comunicativa, sia in Italia che oltre i confini nazionali, questa sarebbe la distinzione tra “mondo vissuto” e “mondo pensato”, tra ciò che si vede con i propri occhi e ciò che si apprende tramite il sentito dire, utilizzando le categorie di Stefano D’Arrigo, recentemente riutilizzate da Giovanni Orsina per analizzare il fenomeno del populismo.

Durante gli ultimi anni, i media mainstream hanno spesso dipinto un mondo idealizzato e inesistente, imponendo una narrazione dall’alto e limitando il dibattito su tematiche importanti come i diritti, l’ambiente, la salute, le migrazioni e l’identità. Questo approccio ha portato alla disconnessione dalla realtà e all’ignoranza di fenomeni politici e sociali significativi, come la vittoria di Donald Trump nel 2016, la Brexit e gli successi elettorali del M5s, che sono stati sottovalutati.
La lotta contro le “fake news” e la “post verità” ha portato a una confusione, dove talvolta la stessa lotta alla disinformazione diventa disinformazione. Ogni media ha una linea editoriale e un’interpretazione della realtà, il problema sorge quando viene presentata come verità assoluta. Questa delegittimazione ha colpito soprattutto la politica, che ha manifestato una crisi profonda nel modo in cui ha affrontato la pandemia. La politica ha ceduto spazi importanti ai tecnocrati e agli esperti senza difenderli, mostrando una mancanza di forza e determinazione.
La crisi ucraina ha segnato il ritorno della politica, affrontando temi cruciali che richiedono un approccio politico e non solo tecnico. Dopo anni di mediazione dal “mondo pensato”, si è assistito a un ritorno al “mondo vissuto”, con tutte le sue sfide, dal populismo al complottismo.
…
Infine, il conflitto non deve spaventare: la politica serve a gestire civilmente le diverse idee, stili di vita e preferenze. Evitare il conflitto porta all’annullamento della politica. I media, a loro volta, devono evitare di impartire prescrizioni morali e cercare di diventare un corpo intermedio che offre criteri per valutare la realtà quotidiana, seguendo il pensiero di Vittorio Emanuele Parsi che sottolineava l’importanza di aiutare le persone a riallinearsi con la realtà.